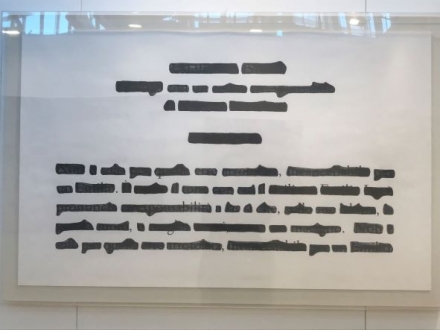L'uomo che uccise Don Chisciotte
Un progetto coltivato per 25 anni trasformato in un'operazione metalinguistica di riflessione e messa in scena della "macchina" del cinema

Come ci ricorda lo stesso regista all’inizio del film, ci sono voluti ben 25 anni perché Terry Gilliam riuscisse a portare sullo schermo la sua ossessione, realizzando finalmente la sua versione del Don Chisciotte.
Una gestazione lunghissima e travagliata che, in parte, era già stata raccontata nel documentario Lost in La Mancha che narrava il fallito tentativo di trasposizione avvenuto tra il 2000 ed il 2002.
Inevitabilmente il peso di tutti questi anni e di tutti i cambiamenti subiti dal progetto, a partire dal cast, si riflettono sul risultato finale.
Don Chisciotte è un film sfilacciato che non riesce mai a trovare un vero e proprio filo conduttore ed un suo ritmo. Appare più come l’insieme di una serie di episodi debolmente tenuti insieme in cui il regista sembra procedere per accumulo, sempre alla ricerca dell’effetto stupefacente, tra scenografie barocche e scene piene di personaggi e di cose che accadono che però rischiano solo di provocare l’indigestione.
Tuttavia, se lo si guarda da un altro punto di vista, il risultato finale è estremamente interessante ed appare quasi un saggio sulla macchina cinema.
L’ultima fatica di Gilliam diventa così un gioco di specchi e di scatole cinesi dove realtà e finzione dialogano costantemente tra loro.
Lo stesso incipit con la voce dell’autore palesa la dimensione di fiction di ciò che andremo a vedere, introducendo la cifra del film.
Ecco che entra in scena Toby (Adam Driver), regista alle prese con uno spot con protagonista il primo Don Chisciotte che vedremo.
Tra un’avventura con Jacqui (Olga Kurylenko), moglie del produttore (Stellan Skarsgård), ed un capriccio da star il nostro, fortuitamente, ritrova la copia in dvd del suo primo film, realizzato quando ancora era uno studente, e si tratta proprio de L’uomo che uccise Don Chisciotte.
Si ha come l’impressione che questo film nel film, realizzato in bianco e nero e del quale vediamo ampi spezzoni, sia forse ciò che veramente avrebbe voluto girare Gilliam, il nucleo del suo progetto originario e forse anche la parte più affascinate di esso.
Ritrovato il film il nostro, spinto dalla curiosità e dalla nostalgia, parte alla volta del paesino dove lo aveva realizzato scoprendo così che quel suo lontano lavoro ha avuto conseguenze sulle vite dei protagonisti di quella pellicola.
L’allora giovane Angelica (Joana Ribeiro) è diventata una escort di lusso ed ora è praticamente proprietà di un ricco produttore di vodka russo, il quale, a sua volta, ha proprio contattato il produttore dello spot di Toby per realizzare la sua prossima campagna pubblicitaria.
Il vecchio ciabattino Javier (Jonathan Pryce), invece, è rimasto prigioniero della finzione ed è convinto di essere il vero Don Chisciotte; così quando incontra Toby riconosce in lui il suo fedele scudiero Sancho Panza e l’avventura può partire.
Ed arriviamo così al terzo (ma non ultimo) Don Chisciotte che poi è il film vero e proprio.
A questo punto, il gioco di scatole cinesi messo in scena sino a questo momento si trasforma in un film dove la finzione del cinema viene continuamente palesata e dove finzione e realtà si intersecano tra di loro.
Viene in mente il finale de La montagna sacra quando lo spettatore scopre di aver assistito ad una troupe intenta a girare un film o quello straordinario atto di amore per il mestiere di regista che è Effetto notte.
Sarà meglio però fare alcuni esempi per chiarire.
Quando Toby giunge nella locanda dove anni prima lavorava Angelica, i dialoghi tra lui e l’oste, nonché padre della ragazza, si svolgono in spagnolo con sottotitoli in inglese. Quand’ecco che Toby dice “non abbiamo bisogno di questi” e con un gesto della mano spazza via i sottotitoli in un’operazione meta cinematografica di svelamento della finzione eccelsa.
Ed ancora lo scontro tra Don Chisciotte ed un cavaliere nemico in realtà altro non è che una messinscena degli abitanti del villaggio che cercano di far rinsavire il vecchio.
Lo stesso dicasi per l’apparizione di un corteo medievale; penseremmo di essere stati catapultati anche noi nel sogno di Don Chisciotte ma si tratta solo degli invitati alla festa del magnate russo.
Si potrebbe andare avanti a lungo ma tutto il film di Gilliam è costruito così, su episodi che sembrano una cosa ma si rivelano presto un’altra svelando così una doppia faccia.
Le monete d’oro trovate da Toby sono solo pezzi di ferro, il sacrificio finale di Angelica è solo l’ennesimo trucco realizzato con i mezzi tipici del cinema ed il viaggio di Don Chisciotte verso la luna una rappresentazione teatrale per intrattenere gli ospiti, realizzata esattamente come si farebbe una sequenza di cinema.
Qui siamo alla cavalcata finale de I tre volti della paura in cui Bava mostra i suoi assistenti che corrono intorno a Boris Karloff con alberi finti mentre lui cavalca su di un cavallo a dondolo.
Il cinema che mette in scena sé stesso svelando i propri trucchi, la realtà che si trasforma in finzione filmica e viceversa in un continuo gioco di rimandi e di specchi, il teatro all’interno della pellicola.
Gilliam si diverte come un pazzo a confondere i piani, a giocare con lo spettatore ed intanto, senza darlo a vedere, riflette su quella macchina produttrice di sogni che è il suo mestiere mettendosi in scena in prima persona.
Una grandissima operazione metalinguistica di riflessione sul cinema ed anche su ciò che è diventato (la cartapesta contrapposta alla computer grafica), sino a quel finale al tramonto in cui sembra quasi di vedere Gilliam, finalmente libero dalla sua ossessione, pronto per nuove avventure.
EMILIANO BAGLIO